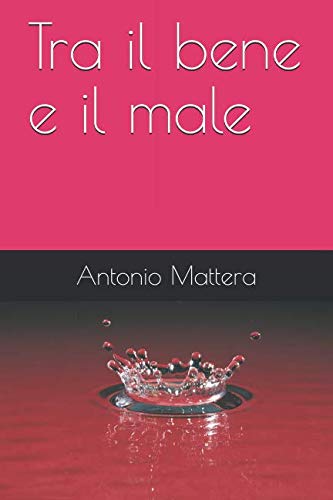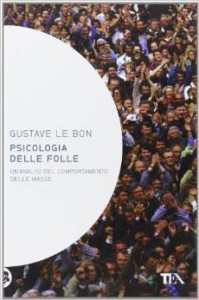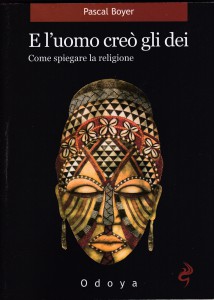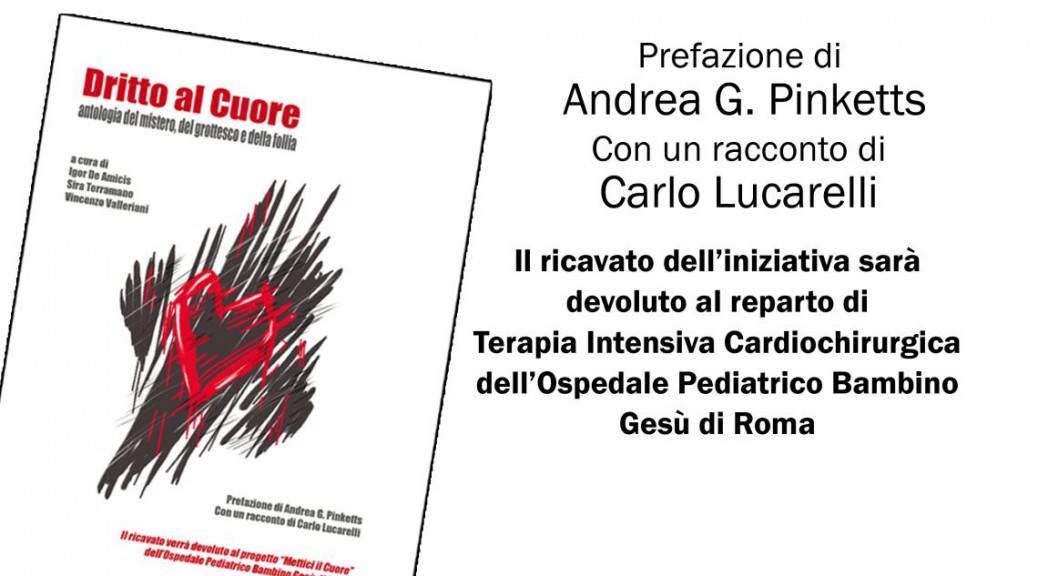NEL BENE, NEL MALE
(di Antonio Mattera)
CAPITOLO 1
Quanto prima ho raccontato l’ho potuto ricostruire anni dopo, ma non crediate che abbia usato poi tanta fantasia!
Ciò che invece mi appresto a narrare sono ricordi vividi, impressi nella mia mente.
E, a volte, nella mia pelle.
Torniamo all’orfanotrofio, la mia prima vera casa.
Naturalmente le buone suore, tra una preghiera e un altra, cercavano qualcuno che potesse prendersi carico del marmocchio.
Ma niente, neanche il più minimo interesse sviluppò quel piccolo involucro di carne che ero io.
Forse furono i miei pianti da neonato, qualche visita nelle ore nelle quali il pannolone era più pieno o qualche poppata andata di traverso, tutti elementi atti a scoraggiare qualche avventuroso.
Se mai ci fu questo avventuroso!
Ad essere carino lo ero, come lo testimonieranno anche i fatti futuri.
E la costituzione sana e robusta non mi mancava.
Ma offerte, di una possibile famiglia, niente!
Ero come un prodotto ignorato in una nicchia dal droghiere.
Arrivai così alla tenera età di 5 anni, e le cose incominciarono a farsi leggermente più difficili.
Gattonare ti permette una certa agiatezza, incominciare a camminare con le tue gambe è un preludio alle libertà future, parlare e lavarti i denti da solo ti immettono nel mondo noioso della scuola.
E così iniziarono le lunghe e tediose giornate con asticelle, cerchi, zampette, numeri e via dicendo.
Una fatica vergarle, ma ancora più faticoso impararle a decifrare, connetterle.
Insomma imparare a leggere!
Ma tant’è, tra qualche nerbata sulle mani e qualche punizione corporale, riuscii a superare anche questo.
Intanto feci la conoscenza con i miei primi amici, altri bambini come me: Adam il grassottello, Tom dalla pelle color ebano, Moosey con la gamba corta.
E, sopratutto, Myriam, dai capelli rossi e le lentiggini sulle guance.
Eravamo una trentina di ragazzini, dai 3 ai 12 anni, e dividevamo il nostro tempo tra lo studio, qualche lavoretto nell’orfanotrofio e lo sbadiglio in occasione dei momenti di preghiera che dovevamo affrontare quotidianamente.
Una routine noiosa che, a nostro parere, solo alcuni di noi avevano la fortuna di interrompere allorché erano chiamati a svolgere qualche incarico nella stanza della Madre superiore, suor Francine.
Spesso toccava a Myriam officiare questi “particolari” compiti.
Si sussurrava che le venissero dati anche dei dolci, se li svolgeva bene.
Quindi logico intuire che ci sentissimo particolarmente invidiosi della fortuna che capitava a lei e agli altri!
A loro volta, però, Myriam e altri bambini, che godevano di questo “trattamento di favore”, sembravano non esserne particolarmente entusiasti.
Myriam, fra l’altro, pareva abbastanza sbadata nel loro compimento, in quanto, dai lividi che riportava, sembrava sempre dimenticarsi di questo o quell’altro spigolo presente nella stanza della madre superiore.
Eppure doveva conoscerla bene!
Uno dei compiti, dall’età di otto anni, che mi veniva assegnato, era di nutrire i piccioni che avevano le suore sull’attico dell’orfanotrofio.
Mi piaceva oltre modo quel compito, potendo, da lassù, godere della vista della campagna tutta intorno a noi e lasciare le briglie della fantasia scorrere nell’immaginario di un mondo esterno che non conoscevo.
O meglio, quello che conoscevo del mondo esterno si limitava al fattore Hershel e al suo camioncino che portava il latte e altri alimenti, la posta e quanto altro abbisognava al nostro sostentamento.
Puntualmente doveva recarsi da Suor Francine per discutere il pagamento della merce portata, ma la discussione, pur durando in media mezz’ora nel segreto della stanza della superiora, non doveva essere particolarmente astiosa, visto che dopo uscivano entrambi molto contenti.
Comunque, torniamo a quell’attico e ai nostri piccioni.
Stavo fantasticando su mille avventure quando mi accorsi che non ero solo.
Una figura esile, avvolta nello scialle verde che ben conoscevo, era ritta sul cornicione dandomi le spalle.
I capelli rossi erano scompigliati dalle piccole raffiche di vento autunnale.
Ma quelli, i capelli al pari dello scialle, erano dettagli ininfluenti.
Avrei riconosciuto Myriam anche senza vederli.
Ne sentivo ogni volta il profumo della sua pelle, anche da lontano.
Era qualcosa di particolare che trascendeva l’uso dei sensi.
Anni dopo qualcuno mi avrebbe detto che era una questione di “chimica”.
Mi avvicinai cauto a lei. Non volevo spaventarla, essendo ritta sul cornicione. Che modo stupido di giocare, pensai fra me e me.
«Myriam, cosa fai qui? Come sei uscita qua fuori?»
Lei si voltò verso di me.
Le lentiggini erano offuscate, sotto l’occhio destro, da un alone viola.
Doveva aver battuto su un altro spigolo, pensai quasi infastidito della sua scarsa attenzione per se stessa.
«Ciao, Glen. Hai lasciato il chiavistello aperto»
Mi girai e compresi.
Che stupido che ero stato!
Le suore non facevano salire mai nessuno sull’attico, tranne me per quel particolare compito.
Avevano munito la porta dal lato interno di serratura,della quale custodivano gelosamente la chiave.
All’esterno della porta vi era un chiavistello da tirare, in modo tale da impedire l’accesso all’attico, per chiunque provenisse da dentro, mentre si era là fuori per qualsiasi motivo.
Quel giorno, preso nelle mie fantasie, mi ero dimenticato di tirarlo.
«Scendi da lì, Myriam, e torna dentro, altrimenti le suore potrebbero incavolarsi di brutto, se ti scoprono. E magari mi tolgono questo incarico.»
«Ci tieni tanto, Glen?»
Scrollai le spalle.
«Mi piace, mi permette di vedere il mondo di fuori. E poi i piccioni sono una buona compagnia, o, quantomeno, non fanno domande né sgridano.»
La guardai negli occhi.
In un certo qual modo, ci eravamo sempre stati simpatici, benché Myriam avesse un paio di anni più di me .
«E a te non piacciono i tuoi compiti?» le chiesi.
«No. Per niente.» fu la sua laconica risposta, senza nemmeno guardarmi.
Ero stupefatto, non capivo il perché.
Certo, ogni tanto si procurava qualche livido, ma pensavo che il dolore svanisse subito, sopratutto quando lo potevi calmare con una bella e succosa caramella.
«Eppure, dovrebbero piacerti! Ti danno anche dolci e leccornie!»
Ancora oggi ricordo il sorriso triste di Myriam in risposta a quella mia fanciullesca e, oggi capisco, stupida affermazione.
«Ah, ecco quello che pensate!»
Mise una mano nella tasca e tirò fuori quelle che, per noi ragazzi, allora erano un piccolo tesoro: caramelle al miele!
Allungò la mano verso di me.
«Prendile Glen, sono tue. Te le regalo.»
Eccome se le avrei volute prendere!
Solo che non mi pareva giusto, erano sue, frutto del suo lavoro.
Allora non ero ancora carogna come oggi.
E forse quel giorno ha contributo a farmi diventare quello che sono.
Ma bando alle chiacchiere e torniamo a quel pomeriggio, a quell’attico, a me e Myriam.
Agitò la mano che impugnava le caramelle davanti al mio volto e mi ripeté convinta:
«Prendile, Glen, sono tue, davvero!».
Nella sua voce c’era quasi un tono d’ implorazione.
La cosa mi mise in imbarazzo e riuscii a bofonchiare solo una timida risposta.
«Non posso, Myriam, non sarebbe giusto! Suor Francine ti da queste caramelle come ricompensa per i tuoi compiti.»
Lei mi guardò con quei suoi occhi verdi e solo allora mi accorsi che piccole lacrime le solcavano il viso.
Fece un cenno col capo e rispose con un laconico «Capisco.»
Si rigirò e fece compiere al braccio, con il quale mi aveva porto quelle caramelle, un movimento rotatorio verso l’alto.
Arrivata a mezza via, la mano si aprì e le caramelle volarono oltre il parapetto.
Sembrò quasi che rimanessero sospese per un attimo, ma, subito dopo, le vedemmo cadere giù come stelle cadenti e scomparire alla nostra vista.
Mi avvicinai al parapetto e guardai giù.
Le caramelle erano li, cinque piani sotto di noi, macchioline quasi invisibili sparpagliate sul selciato.
Mi voltai verso Myriam.
Ero infuriato con lei, ma anche confuso.
Preoccupato.
Non per le caramelle, naturalmente, ma per la mia amica dai capelli rossi.
Sapevo benissimo che se le suore avessero trovato quelle caramelle avrebbero capito che era stata Myriam a gettarle via.
Le avrebbero raccolte, portate a Suor Francine e Myriam avrebbe anche potuto prendersi qualche punizione ( la più frequente, e io ne sapevo qualcosa a riguardo, era qualche nerbata sulle mani con un frustino ottenuto da una pianta).
«Perché l’hai fatto?» avrei voluto che il mio tono risultasse più irato, in realtà ne usci fuori un misto fra la disperazione e il rassegnato.
«Hai paura per te o per quello che potrebbe succedere a me, Glen ?»
«Cavoli, Myriam, ma non capisci proprio in che guai ti vai cacciando?»
Lei prese la mia faccia fra le sue mani, anche esse punteggiate dalle lentiggini, e mi fissò dritto negli occhi.
Solo allora potei notare che le sue iridi verdi erano due isole che stavano per essere sommerse da un mare di lacrime.
La sua voce uscì roca, rotta dal pianto.
«Credi tu che ci sia qualcosa che mi possa far paura dopo quello che ho subito? Tu o gli altri non avete idea di cosa significano quelle caramelle per me!»
«Myriam, io…»
«Taci, Glen! Neppure puoi concepire l’inferno dal quale provengono. Non sono il premio per i miei servizi, ma il dazio per il mio silenzio!»
Si voltò dandomi le spalle, cingendosi il corpo con le sue esili braccia.
Potevo sentire il suo roco singhiozzo percuoterne il corpo.
Il vento gelido che soffiava sulla Cumbria in quella stagione ci sferzava i volti e portava via da lei qualche piccola lacrima.
Cercai le parole giuste per confortarla, ma sentivo dentro di me che qualcosa era rotto per sempre nell’animo di Myriam.
Rimasi immobile là, su quell’attico.
Quell’attimo di silenzio, quel momento che rimase vuoto di una qualsiasi parola, anche la più stupida, che io potessi pronunciare, quel fermarsi staticamente ad aspettare l’ evolversi degli eventi, è stato, a distanza di anni l’ho capito, il tempo più sprecato della mia vita.
Avrei potuto impegnarlo in mille modi, ognuno dei quali, probabilmente, non avrebbe portato a quanto avvenne in seguito.
O, forse, non sarebbe cambiato nulla.
Myriam salì sul parapetto e si voltò verso di me.
«Ti ricordi, Glen, come ci chiama Suor Francine?»
Confuso, ignaro di quanto stesse accadendo, o forse talmente consapevole da esserne inebetito, non riesco ancora oggi a capirlo, annuii col capo.
«I suoi piccoli angeli» fu la mia risposta
Myriam mi sorrise, ora non piangeva più.
«Esatto, Glen, i suoi angeli! E gli angeli hanno ali. Anche per fuggire via.»
Allargò le braccia e, dopo un ultimo sorriso, si spinse all’indietro, nel vuoto.
Per un attimo sperai che si potesse librare nel cielo proprio come un angelo, e riapparisse al di sopra del parapetto.
Fu questione di secondi, anche se parvero infiniti, e un rumore sordo, tipico, come ora conosco, di un corpo che impatta il suolo, giunse alle mie orecchie.
Nel corso degli anni quel rumore mi ha accompagnato, facendomi risvegliare di soprassalto madido di sudore, oppure riaffacciandosi spontaneamente nei miei ricordi all’ascolto di altri rumori simili.
Ma niente è mai stato paragonabile ad esso: è come se potessi ascoltare, in un unico suono, tutte le ossa andare in frantumi singolarmente, le vene collassare, gli organi interni esplodere.
Quando uscii da quella sorta di sogno ad occhi aperti, mi diressi al parapetto e guardai giù.
Myriam era là.
No, non era un angelo.
No, non era più nemmeno una persona.
Viva almeno.
Lo capii dalla macchia rossa che andava allargandosi dietro la sua testa.
Un piccolo lago che sembrava prendere il suo colore da quello, rosso, dei capelli della mia amica.
Solo un po’ più scuro.
Come lo è solo il sangue.
Schizzi di materia cerebrale si confondevano sul selciato.
Insieme alle caramelle.
Nausea e pianto sopraggiunsero insieme.
La bocca, piena del sapore acidulo del vomito, inutilmente cercava sollievo dalle lacrime che si riversavano dentro, dopo aver solcato il mio viso.